Rao Raja e l'inglese
Ovvero: se lo dice lui...
Mentre qui sul blog mi dedicavo al "trio" (Anand, Narayan e Rao Raja), fra le quinte ho continuato la discussione con Paritosh sull'autenticità o meno dello scrivere in inglese.
Io non sono particolarmente scandalizzata da una possibile mancanza di autenticità, per i motivi di cui ho già detto, ma capisco il suo punto vista quando dice che alcuni libri sono impacchettati apposta per un pubblico occidentale che si esalta se legge di spezie, sari e monsoni ma non capisce niente dell'India.
Siamo arrivati a questo punto: un libro non è autentico se ciò che l'autore scrive è determinato dal lettore e non dalla penna dello scrittore (perché, l'autore, checché ne dica, ha sempre un lettore in testa...).
 Dopo essere arrivati a questa conclusione per email, ieri sera ho ripreso in mano Kanthapura di Rao Raja e ho riletto, ancora una volta, la prefazione scritta dall'autore. Mi ha colpito quello che dice sulla sua scelta di scrivere in inglese (lui era di madrelingua Kannada, la ling
Dopo essere arrivati a questa conclusione per email, ieri sera ho ripreso in mano Kanthapura di Rao Raja e ho riletto, ancora una volta, la prefazione scritta dall'autore. Mi ha colpito quello che dice sulla sua scelta di scrivere in inglese (lui era di madrelingua Kannada, la ling
ua di Bangalore, per intenderci).
Quali migliori parole per descrivere perché si scrive in inglese, se non quelle di chi ha "inventato" la scrittura indiana in lingua inglese?
Ecco allora qui le parole di Rao Raja.
Ricordo e sottolineo: sono del 1938. Rushdie, Arundhati Roy, Ghosh, i due Vikram & Company non erano ancora nati e, anzi, ne avevano ancora parecchio prima di venire al mondo.
Io non sono particolarmente scandalizzata da una possibile mancanza di autenticità, per i motivi di cui ho già detto, ma capisco il suo punto vista quando dice che alcuni libri sono impacchettati apposta per un pubblico occidentale che si esalta se legge di spezie, sari e monsoni ma non capisce niente dell'India.
Siamo arrivati a questo punto: un libro non è autentico se ciò che l'autore scrive è determinato dal lettore e non dalla penna dello scrittore (perché, l'autore, checché ne dica, ha sempre un lettore in testa...).
 Dopo essere arrivati a questa conclusione per email, ieri sera ho ripreso in mano Kanthapura di Rao Raja e ho riletto, ancora una volta, la prefazione scritta dall'autore. Mi ha colpito quello che dice sulla sua scelta di scrivere in inglese (lui era di madrelingua Kannada, la ling
Dopo essere arrivati a questa conclusione per email, ieri sera ho ripreso in mano Kanthapura di Rao Raja e ho riletto, ancora una volta, la prefazione scritta dall'autore. Mi ha colpito quello che dice sulla sua scelta di scrivere in inglese (lui era di madrelingua Kannada, la lingua di Bangalore, per intenderci).
Quali migliori parole per descrivere perché si scrive in inglese, se non quelle di chi ha "inventato" la scrittura indiana in lingua inglese?
Ecco allora qui le parole di Rao Raja.
Ricordo e sottolineo: sono del 1938. Rushdie, Arundhati Roy, Ghosh, i due Vikram & Company non erano ancora nati e, anzi, ne avevano ancora parecchio prima di venire al mondo.
"Raccontarla [questa storia] non è stato facile. Bisogna rendere in un linguaggio che non è il proprio lo spirito di vicende che invece ti appartengono. Bisogna rendere le varie sfumature e omissioni di un determinato movimento del pensiero, che in una lingua straniera appare trattato malamente. Uso la parola "straniera", tuttavia l'inglese non è per noi una lingua veramente straniera. E' la lingua del nostro corredo intellettuale, come prima lo erano stati il sanscrito e il persiano, ma non del nostro corredo di emozioni e sentimenti. Noi tutti siamo per istinto bilingui, molti di noi scrivono nella propria lingua e in inglese.
Non possiamo tuttavia scrivere come gli inglesi. Non dovremo. Ma non possiamo neppure solo scrivere come indiani. Siamo abituati a considerare la vasta distesa del mondo come parte di noi stessi. Di conseguenza, il nostro modo di espressione deve essere un dialetto tale da rivelarsi, un giorno, altrettanto autonomo e ricco di sfumature personali di quanto non lo sia oggi l'irlandese o l'americano. Solo il tempo potrà giustificare il carattere specifico del nostro modo di parlare e di scrivere."
Non possiamo tuttavia scrivere come gli inglesi. Non dovremo. Ma non possiamo neppure solo scrivere come indiani. Siamo abituati a considerare la vasta distesa del mondo come parte di noi stessi. Di conseguenza, il nostro modo di espressione deve essere un dialetto tale da rivelarsi, un giorno, altrettanto autonomo e ricco di sfumature personali di quanto non lo sia oggi l'irlandese o l'americano. Solo il tempo potrà giustificare il carattere specifico del nostro modo di parlare e di scrivere."


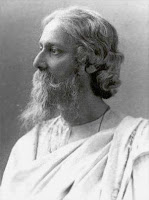
Mi sembra che la chiave di tutta questa storia stia proprio in queste tue righe: "un libro non è autentico se ciò che l'autore scrive è determinato dal lettore e non dalla penna dello scrittore." Questo è un problema per tutta l'arte contemporanea. Non è l'artista a "guidare" con le sue emozioni il suo pubblico, ma è lui ad essere determinato dal suo pubblico, questo è molto chiaro nell'arte figurativa contemporanea. L'arte, e quindi anche la letteratura, si è "marketizzata". Brava Silvia, hai toccato un punto fondamentale! Infatti credo che il nostro compito sia quello di capire meglio quello che sta succedendo e non fermarci a scandalizzarci e a piangere. Certamente il tuo blog va in questa direzione. A riparlarne presto. Un abbraccio, cris
RispondiEliminaCara Cristina,
RispondiEliminarispondo solo ora al tuo interessantissimo commento...
Penso che sia veramente difficile stabilire che cosa sia autentico e cosa no. D'altra parte, non è detto che una cosa autentica abbia necessariamente più valore di una non autentica.
Non so quanto c'entri con quello che dici, ma mi hai fatto venire in mente che in passato, spesso, l'artista non era guidato dal lettore (in inglese suona anche meglio: reader-driven), ma da un committente.
Forse oggi lettore e committente sono diventati un'unica entità, perché poi è quest'unica entità che "paga". Che poi, alla fine, è esattamente come dici tu: l'arte si è marketizzata.
Come tutto il resto, poi.
Prendiamone atto: non è un buon motivo per farne a meno...